La polemica tra i Radiohead e BDS non nasce oggi, né ieri.
Ha una data precisa incisa nella memoria di chi, nel luglio del 2017, guardava a Gerusalemme Est come a un punto di rottura della Storia. Lì, nel cuore di una città che è ferita e simbolo, luogo sacro e prigione, le autorità israeliane reprimevano, con durezza, le proteste dei palestinesi contro le misure di sicurezza imposte al complesso di al-Aqsa. Era un momento incandescente, uno dei tanti che punteggiano la lunga cronaca dell’occupazione — perché va ricordato, senza infingimenti: Gerusalemme Est è territorio occupato illegalmente secondo il diritto internazionale, così come la Cisgiordania.
 Ed è in quei giorni che i Radiohead si apprestavano a suonare a Tel Aviv. Non in un luogo neutro. Non in una sala astratta dal mondo. Ma in uno Stato accusato apertamente — da ONU, ONG, giuristi, storici — di praticare forme sistematiche di apartheid contro la popolazione palestinese.
Ed è in quei giorni che i Radiohead si apprestavano a suonare a Tel Aviv. Non in un luogo neutro. Non in una sala astratta dal mondo. Ma in uno Stato accusato apertamente — da ONU, ONG, giuristi, storici — di praticare forme sistematiche di apartheid contro la popolazione palestinese.
Già allora BDS, insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani, tentò di convincere la band a cancellare il concerto. Non per attribuire loro una colpa diretta: nessuno riteneva i Radiohead artefici delle violenze, né complici delle decisioni politiche del governo Netanyahu. Ma perché l’arte, quando sceglie uno spazio, sceglie una posizione. E un concerto diventa — volenti o nolenti — un tassello nella narrativa internazionale di uno Stato.
È accaduto altrove, nella storia. Accadde negli anni Ottanta, quando il regime sudafricano dell’apartheid veniva isolato culturalmente e mediaticamente da ogni forma di collaborazione artistica. E allora ci chiediamo: avrebbero mai i Simple Minds, gli U2, i Dire Straits, gli INXS o i Queen accettato di esibirsi in uno Stato che praticava — senza maschere — una segregazione razziale legalizzata?
La risposta è semplice: no. Perché il boicottaggio culturale servì proprio a delegittimare un governo che trattava milioni di persone come sotto-cittadini.
Cos’hanno visto, invece, i Radiohead nel 2017? Forse ritengono che il governo israeliano non sia un governo razzista? O che non pratichi l’apartheid? Se così fosse, perché non dirlo apertamente? Perché non prendere posizione? Perché non sostenere — a viso aperto — ciò che sembrano suggerire con le loro azioni?
Thom Yorke parla, spesso, di “caccia alle streghe”, come se la critica fosse un rituale persecutorio e non un appello morale. Ma la realtà è che i Radiohead, da allora, hanno scelto l’ambiguità come rifugio. Un’ambiguità che si traduce in un linguaggio diplomatico, sfumato, strategico, utile a non svuotare le arene, a non perdere consenso, a non incrinare la narrazione del “genio artistico superiore alle ideologie”. Un’ambiguità che — negli anni — si è trasformata in una coltre sempre più spessa: parole prudenti, mezze frasi, equidistanza.
rifugio. Un’ambiguità che si traduce in un linguaggio diplomatico, sfumato, strategico, utile a non svuotare le arene, a non perdere consenso, a non incrinare la narrazione del “genio artistico superiore alle ideologie”. Un’ambiguità che — negli anni — si è trasformata in una coltre sempre più spessa: parole prudenti, mezze frasi, equidistanza.
Ma come si può essere equidistanti quando una parte dispone di armi, potere politico e sostegno militare internazionale, mentre l’altra vive sotto occupazione, subisce bombardamenti, restrizioni, confische, demolizioni, arresti di massa, apartheid legale? Che senso ha invocare la simmetria quando la realtà è così asimmetrica?
Jonny Greenwood, rispondendo alle critiche, ha sempre difeso il diritto degli artisti a collaborare tra loro. Ed è vero: nessuno contesta la cooperazione artistica tra gli individui. Ma il problema non era — e non è — collaborare con musicisti israeliani. Il punto è collaborare con un artista, Dudu Tassa, che ha sostenuto l’IDF, l’esercito che a Gaza — e non solo — è stato accusato da giuristi e tribunali internazionali di crimini contro l’umanità. Come si può ignorare questo? Come può farlo una band che ha costruito la propria narrativa artistica sul dolore dei deboli, sulla fragilità dell’uomo, sulle ombre del potere?
I Radiohead continuano a nascondersi dietro i loro silenzi, a parlare di equidistanza mentre tutto intorno il mondo collassa in una spirale di ingiustizia. Non saranno loro a fermare le bombe, è evidente. Ma la loro ambiguità, oggi, pesa più della loro musica. Pesa sulle coscienze di chi li ha amati, di chi riconosceva in loro una voce fuori dal coro, un sussurro di vulnerabilità contro la brutalità del mondo. Pesa sulle aspettative tradite di un pubblico che avrebbe voluto vederli essere ciò che hanno sempre cantato: empatici, lucidi, umani.
E allora sì, possiamo dirlo: sono artisti immensi, spesso rivoluzionari nel suono, ma, politicamente, uomini insondabilmente piccoli.
La loro musica resta. Ma la loro postura — questa postura — rischia di oscurarla. Perché l’arte può anche non essere militante. Ma non può essere cieca. E davanti a un’ingiustizia così vasta, così documentata, così atroce, il silenzio e l’ambiguità non sono neutralità: sono una forma di complicità.









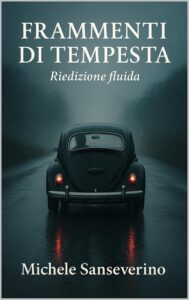
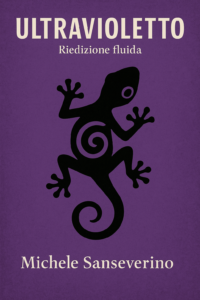















Comments are closed.