Trame sonore brucianti, che scorrono come vene incandescenti sotto una superficie di ghiaccio. Sono linee melodiche che si spezzano e si ricongiungono, che sussurrano come antiche profezie dimenticate, il ricordo di un fuoco interiore che abbiamo soffocato lentamente, giorno dopo giorno. Lo abbiamo coperto con pile infinite di compiti, di promesse vaghe, di impegni che non sapevamo nemmeno di aver accettato, con parole che non ci appartenevano — ed è, con questa zavorra, che stiamo affondando, pian piano, in un’acqua pesante che non perdona.
Siamo canzoni solitarie, ciascuno di noi. E le sonorità crepuscolari dei Dor ce lo sbattono in faccia con una dolcezza crudissima: non abbiamo una vera casa, non abbiamo veri amici, non abbiamo nemmeno una storia coerente da raccontare. Siamo solo riflessi tremolanti su un vetro appannato, immagini sfocate di ciò che credevamo di essere, versioni alternative della favola inquieta che Giorgio Manganelli ha trasformato nel suo Pinocchio, un mondo in cui il burattino non vuole diventare bambino, un mondo in cui la redenzione del “bambino buono” è solo un’arma narrativa della società perbenista, borghese, ipocrita — la stessa del passato, la stessa di oggi.
 È una morale tagliente, arrogante, che ci chiede di rinunciare a tutto ciò che è nostro: la libertà di essere noi stessi, qualsiasi sia la materia che ci compone — carne o legno, fango o fuoco, forza o fragilità, coraggio o vigliaccheria, rumore o silenzio. Ci chiede di indossare la maschera del “giusto”, del “pulito”, del “corretto”, perché così funziona la nostra società: solo chi si adatta sopravvive. Solo chi è docile è accettabile.
È una morale tagliente, arrogante, che ci chiede di rinunciare a tutto ciò che è nostro: la libertà di essere noi stessi, qualsiasi sia la materia che ci compone — carne o legno, fango o fuoco, forza o fragilità, coraggio o vigliaccheria, rumore o silenzio. Ci chiede di indossare la maschera del “giusto”, del “pulito”, del “corretto”, perché così funziona la nostra società: solo chi si adatta sopravvive. Solo chi è docile è accettabile.
Ma i Dor incendiano questa maschera. La frantumano con un suono che è insieme post-rock e preghiera pagana, un lamento folk, un vento che porta via la voce delle divinità finte che abbiamo adorato solamente per paura. La loro musica scava nel terriccio del nostro subconscio, riemerge come un fiume in piena che travolge la finta morale, la bontà di cartapesta, la pulizia di facciata che serve a giustificare le nostre crudeltà: i torti che facciamo, le guerre che sosteniamo, la fede feroce che invochiamo mentre continuiamo a mentire.
Intanto le atmosfere post-rock si espandono in una dimensione più verbosa, un territorio dove parola e suono si sciolgono, si confondono, diventano un’unica creatura. Le chitarre non accompagnano la voce: la trascinano in un’altra geografia. Il verbo si fa musica. La musica si fa visione. Il burattino — il nostro burattino interiore — smette finalmente di obbedire.
Resta sé stesso. Non cede. Non si spiega. Non si giustifica.
Si rivolge all’ultimo lembo di orizzonte, a un tramonto selvaggio e rumoroso, e da lì scivola dentro divagazioni mathcore e fragili esplosioni di luce. È un cielo senza stelle quello che ci mostra il disco, un cielo dove le divinità umane muoiono come lampadine bruciate. E quando tutto tace, quando le bugie collettive cadono come foglie logore, puoi finalmente ascoltare — nitida, profonda, necessaria — la voce vibrante delle forze invisibili dell’universo. Una voce che ci ricorda che non dobbiamo diventare “veri bambini”: dobbiamo solamente tornare ad essere vivi.









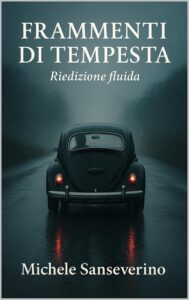
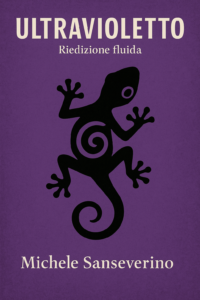















Comments are closed.