PhEST, la manifestazione fotografica che abita Monopoli in questi mesi, sceglie come proprio baricentro il mare. Non un mare qualsiasi, ma quel Mediterraneo che ci appartiene e a cui apparteniamo, crocevia eterno di approdi e di partenze, di destini intrecciati e di memorie ferite. Le storie che arrivano a PhEST nascono da esso, o vi ritornano, come correnti sottili che non smettono mai di legare terre lontane, rendendole magicamente vicine. Sono ponti immaginari che uniscono i popoli, i linguaggi, i sogni e persino i dolori.
 Il Mediterraneo, infatti, non è soltanto una distesa d’acqua, ma è una vera e propria biblioteca liquida, una fonte di conoscenza che custodisce le voci, le testimonianze e i silenzi di civiltà grandiose, nonché i crolli improvvisi, le guerre senza fine, le tragedie indicibili. È un mare che ha dato vita a filosofi, a poeti, a commercianti e a navigatori, ma che, oggi, continua, purtroppo, a reclamare i corpi e le anime di chi fugge da guerre altrettanto micidiali, dalla miseria, dalla violenza o da terre desertificate dalla cupidigia e dalla corruzione. Laddove, un tempo, sorgevano templi e città, oggi sprofondano gommoni, si spezzano famiglie, si consumano perdite evitabili che non avremmo mai dovuto accettare come consuetudine.
Il Mediterraneo, infatti, non è soltanto una distesa d’acqua, ma è una vera e propria biblioteca liquida, una fonte di conoscenza che custodisce le voci, le testimonianze e i silenzi di civiltà grandiose, nonché i crolli improvvisi, le guerre senza fine, le tragedie indicibili. È un mare che ha dato vita a filosofi, a poeti, a commercianti e a navigatori, ma che, oggi, continua, purtroppo, a reclamare i corpi e le anime di chi fugge da guerre altrettanto micidiali, dalla miseria, dalla violenza o da terre desertificate dalla cupidigia e dalla corruzione. Laddove, un tempo, sorgevano templi e città, oggi sprofondano gommoni, si spezzano famiglie, si consumano perdite evitabili che non avremmo mai dovuto accettare come consuetudine.
Albert Camus ci ha fatto comprendere come il Mediterraneo poteva essere una terra promessa di cui, invece, con le nostre scelte e le nostre azioni, abbiamo fatto un inferno. Ed è proprio dentro questa evidente contraddizione che PhEST si colloca: non ignora le ferite, non le nasconde dietro veli estetici, ma tenta di curarle attraverso lo sguardo, il confronto, il racconto visivo. La fotografia, in questo contesto, diventa atto di ricostruzione, un modo per ridare volto a chi lo ha perso, voce a chi non ce l’ha più, memoria a chi rischia l’oblio. PhEST cerca di ricomporre i legami spezzati, di rialzare i ponti frantumati dall’odio e dall’avidità, di trasformare la paura e la diffidenza in dialogo.
Occidente e Oriente, Sud e Nord: nessuna parte può davvero esistere senza l’altra. Non si possono isolare come mondi a parte, né immaginare che una prevalga, cancellando completamente l’altra. Hanno bisogno, come un mosaico antico, di incastrarsi per formare un disegno più ampio, più forte, più duraturo, più resistente, più vero. E la Puglia, terra di confine e di accoglienza, luogo di partenze e di ritorni, incarna, perfettamente, questa vocazione: basti pensare, ad esempio, a Federico II, che proprio da qui tentò un dialogo impossibile eppure necessario, o alle mille narrazioni umane che hanno toccato queste coste, lasciando tracce indelebili.
parte, né immaginare che una prevalga, cancellando completamente l’altra. Hanno bisogno, come un mosaico antico, di incastrarsi per formare un disegno più ampio, più forte, più duraturo, più resistente, più vero. E la Puglia, terra di confine e di accoglienza, luogo di partenze e di ritorni, incarna, perfettamente, questa vocazione: basti pensare, ad esempio, a Federico II, che proprio da qui tentò un dialogo impossibile eppure necessario, o alle mille narrazioni umane che hanno toccato queste coste, lasciando tracce indelebili.
PhEST, allora, è doppio movimento: approdo e partenza, casa e viaggio, memoria e invenzione. È un ponte tra la tradizione e l’innovazione, tra il passato e il futuro. Ci mostra quanto la tecnologia possa essere un alleato prezioso, se non piegata alla logica infame della guerra, ma messa al servizio della vita, della comunicazione, della condivisione di conoscenza e bellezza.
La manifestazione diventa così una porta aperta: su ciò che è stato e non deve più ripetersi, e su ciò che deve ancora venire. Una porta che lascia entrare la luce, ma anche l’ombra, perché entrambe sono necessarie alla consapevolezza. Un monito, dunque, affinché, in Europa e nel mondo, si interrompa il ciclo degli orrori che ancora insanguinano terre vicine e lontane – dall’Ucraina alla Palestina, dalla Libia ad altri angoli invisibili del pianeta – dove uomini, donne e bambini vengono privati dei loro diritti, discriminati o sterminati per ragioni che sono soltanto folli, disumane, false ed odiose.
PhEST è più di un festival: è un atto di esistenza poetica, un invito al dialogo, una dichiarazione d’amore al Mediterraneo e al suo destino, che è anche il nostro.









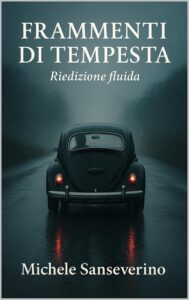
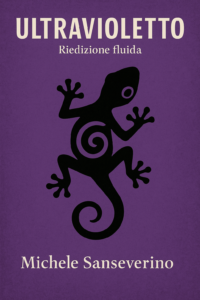















Comments are closed.